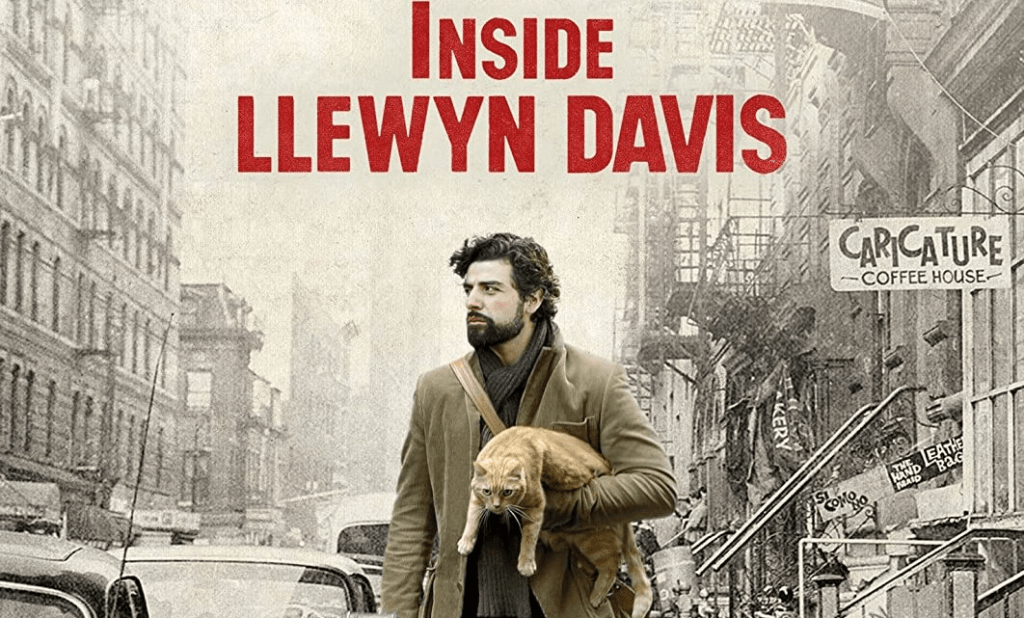(articolo apparso per la prima volta sulla rivista “Odissea” di Angelo Gaccione al seguente link: ODISSEA)
Nelle montagne spagnole in cui si ambienterà la vicenda, era tradizione locale strappare la criniera ai cavalli con l’ausilio delle sole proprie forze, a mani nude. E, subito dopo questa notizia storica, ha inizio l’opera di Sorogoyen, presentata nel 2022 a Cannes. Una coppia francese si è stabilita in un quasi abbandonato villaggio spagnolo. Si è esposta, andando contro la tendenza dei locali, che volevano vendere le terre a un’azienda eolica norvegese, sperando, con il ricavato, in una vita migliore, resa impossibile dai progetti dei due, che diventano bersaglio di una persecuzione da parte di due fratelli del luogo. I quali fratelli, inizialmente, rovinano il raccolto della coppia tramite due batterie poste nel pozzo che alimenta il terreno. E questo evento, quando viene inquadrato, ha l’aria di essere non plus ultra. Non lo è: Antoine, il protagonista, verrà soffocato, tenuto fermo da entrambi i fratelli, com’è lui un uomo estremamente massiccio, alla stessa stregua dei cavalli che vediamo, nella sequenza iniziale al ralenti, venire trattenuti.
Sin dalla prima sequenza – e anche dal titolo – Sorogoyen evidenzia uno dei nuclei tematici portanti del film: il concetto di bestialità, che nel corso della narrazione si declinerà in modi affatto differenti.
As bestas è un film di domande insolute. Netto, preciso, una sorta thriller rurale che vede, nell’epilogo tragico della persecuzione, non lo scioglimento dei nodi ma la creazione di inedite difficoltà per la moglie di Antoine, Olga, rimasta sola. A dire di lei, lui volevano morto mentre lei non rischiava. Ma la sua infinita solitudine non gode di placidità; vive anzi l’oppressione del paese tutto, per essere “moglie di” quello che ha impedito la vendita dei terreni. È più volte esplicitato che, con il ricavato, nessuno avrebbe potuto cambiare vita. E più volte si cita la Storia. Viene attribuita a Napoleone una frase in prossimità del tentativo di invasione della Spagna: “Gli spagnoli sono degli idioti del cazzo”.
È insomma un film di territori. Non solo quelli filmati – che circondano di ameno (scelta che ricorda Midsommar di Ari Aster) il crescendo di barbarie – ma anche quelli respirati, quelli della storia privata dei singoli personaggi. Ma è anche, As bestas, un film di paradossi (il più grande dei quali si rivelerà essere quello della Legge). Sì, perché se, da una parte, gli indigeni sono ovviamente legati a quel villaggio, nulla fanno per mantenerlo vivo; gli unici che agiscono – rifiutando la proposta dell’azienda norvegese – sono Antoine e Olga, che mirano alla ristrutturazione delle case derelitte perché possano un giorno ospitare nuove persone (attività parallela a quella dell’orto).
Si scontrano due griglie valoriali. Quella che, in teoria, provenendo la coppia francese dalla metropoli, si presupporrebbe (con pregiudizio, sì) essere materialista, è in realtà quella a cui il denaro importa poco; gli indigeni, che dovrebbero essere legati alla terra, non vedono l’ora di venderla. Sorogoyen è astuto nel porci Antoine e Olga immediatamente come vittime per cui parteggiare, salvo poi lasciar trasparire le ragioni dei “buzzurri di montagna”. Che, dice il fratello maggiore, uno dei due assassini, hanno condotto una vita a spezzarsi la schiena e, giunta l’occasione per liberarsi dello sforzo senza ricavato alcuno se non una sbronza quotidiana a buon mercato, si vedono strappato il sogno da un altro sogno. Il sogno di chi ha meno diritto a sognare, cioè la coppia francese, stabilitasi lì da due anni soltanto, e che pure – nella trattativa con l’azienda norvegese – è diventata ago della bilancia.
Ed è un nuovo paradosso: è vero che, indipendentemente dal tempo in cui mi trovo in un luogo, i miei diritti sono identici a quelli di chi nel luogo vi è nato, ma questo è il modo giusto di vederla. Il film propone – fin dall’inizio – un’altra visione. Si badi, a scanso di equivoci, Sorogoyen non giustifica l’omicidio di Antoine e confeziona un film che è anche (solo superficialmente, ad avviso di chi scrive, contro la xenofobia), ma propone la visione animale del mondo. Se un animale ha fatto tana in uno spiazzo, e un altro animale, in un tempo successivo, a sua volta vi fa tana, a decidere per lo spiazzo – ripeto, nella logica animale che fortunatamente non ha Costituzione scritta – non sarà mai l’animale venuto dopo. Sorogoyen è onesto, nel suo prendere posizione a favore di Antoine e Olga, nel mostrarci le fila del ragionamento dei violenti e, diciamolo di nuovo, ingiustificabili comprimari.
E lo diciamo di nuovo perché As bestas – film di genere a tutti gli effetti che riesce a ricoprirsi di strati semantici su strati semantici – parla della battaglia per agire e vivere nella legalità contro il sopruso, ma trasla quella che avrebbe potuto essere una pellicola di stampo legale in un contesto che va alla radice dei conflitti umani, alla radice brutale delle dinamiche di potere, alla mera sopraffazione, alla bestialità. Viene affrontato il concetto di terra e di appartenenza con un tono che è quasi da parabola biblica, dove la prima immagine dei cavalli si sovrappone allo strangolamento (lungo perché difficile, difficile perché ammazzare è difficile – e questa è etica dello sguardo, come insegna Nanni Moretti nell’ultimo Il sol dell’avvenire) di Antoine. Si trasforma poi, As bestas, in un film sul concetto di giustizia e sulle sue aporie. Perché, morto Antoine, nessuno che se ne sia importato. E i colpevoli – a tutti noti – sono rimasti impuniti.